Se c’era una cosa che non volevo fare era occuparmi di questo tema; tuttavia, rendendomi conto in prima persona sia dell’importanza dell’argomento che del fatto che l’informazione latita, obtorto collo ho deciso di analizzare il problema e, tramite questo articolo, diffondere la sintesi di ciò che ho capito.
Partiamo dal fatto che la recente sentenza della Corte costituzionale sul referendum abrogativo riguardante l’autonomia differenziata (2025) ha riacceso il dibattito sull’effettiva capacità dello strumento referendario di esprimere la volontà popolare in contesti normativi complessi (2).
L’istituto del referendum abrogativo, introdotto dall’art. 75 della Costituzione italiana, rappresenta storicamente uno dei principali meccanismi di democrazia diretta, ma la sua applicazione pratica solleva interrogativi sempre più pressanti sulla compatibilità con i sistemi di governo rappresentativo, sulla qualità del processo decisionale collettivo e sull’equilibrio dei poteri costituzionali.
L’analisi delle ultime tornate referendarie dimostra come questo strumento sia oggi al centro di tensioni istituzionali, difficoltà tecniche e paradossi politici che ne minano l’efficacia (1) (6).
La natura giuridica del referendum abrogativo e il suo ruolo costituzionale
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 75 Cost. configura il referendum come strumento di controllo popolare sulle leggi ordinarie, escludendo espressamente la possibilità di abrogare leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di ratifica dei trattati internazionali.
Questa delimitazione risponde all’esigenza di preservare aree sensibili dell’ordinamento da interferenze destabilizzanti, ma lascia ampio spazio a controversie interpretative sulla natura e i limiti dell’istituto (5).
La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente elaborato quattro criteri di inammissibilità: eterogeneità del quesito, violazione di principi costituzionali, mancanza di coerenza nella normativa residua e oscurità della proposta (3) (5).
La dialettica tra democrazia diretta e rappresentativa
Il referendum abrogativo nasce come correttivo alle distorsioni del sistema parlamentare, ma il suo utilizzo sempre più frequente in chiave antagonista ha trasformato lo strumento in un’arma politica.
Come evidenziato nella sentenza n. 16/1978, la Corte costituzionale ha il compito di garantire che le richieste referendarie mantengano una “matrice razionalmente unitaria”, evitando che diventino veicoli per scelte di indirizzo politico generale (5).
Questo delicato equilibrio spiega perché il 67% dei referendum proposti tra il 2018 e il 2023 sia stato dichiarato inammissibile (1).
Vantaggi e potenzialità dello strumento referendario
Il controllo popolare sul legislatore
Nei casi in cui il Parlamento appaia sordo alle istanze sociali, il referendum costituisce l’unico strumento costituzionalmente previsto per bypassare l’inerzia legislativa.
L’esperienza del referendum sul divorzio (1974) e di quello sulla legge elettorale (1993) dimostra come consultazioni ben formulate possano correggere scelte politiche percepite come distanti dalla volontà popolare (6).
La recente proposta di abrogazione totale della legge sull’autonomia differenziata (2025) rientra in questa logica, pur essendo naufragata per vizi formali (2).
La funzione pedagogica del dibattito pubblico
Anche quando non raggiunge il quorum, il processo referendario innesca un dibattito nazionale su temi trascurati dall’agenda politica.
Il caso del referendum sull’eutanasia legale (2021) ha mostrato come la campagna referendaria possa educare i cittadini su questioni complesse, indipendentemente dall’esito della consultazione (6).
Criticità e rischi dell’istituto referendario
L’incertezza giurisprudenziale e i criteri di ammissibilità
La giurisprudenza “a tornate” della Corte costituzionale (1) crea un clima di prevedibile imprevedibilità che scoraggia l’utilizzo responsabile dello strumento.
L’esigenza di bilanciare principi costituzionali contrastanti (art. 1 sull’autodeterminazione popolare vs art. 138 sulla rigidità costituzionale) genera standard valutativi fluttuanti, particolarmente evidenti nelle sentenze sulle leggi elettorali (5).
La bocciatura del referendum sull’autonomia differenziata per “mancata chiarezza del quesito” (2) ripropone il problema della discrezionalità giudiziale in materie ad alto contenuto politico.
La distorsione della funzione abrogativa
L’art. 75 prevede l’abrogazione di singole norme, ma i comitati promotori ricorrono sempre più spesso a strategie legislative complesse per aggirare i limiti costituzionali.
Il tentativo di abrogare selettivamente le clausole abrogative della legge Calderoli (2012) (4) dimostra come tecniche di drafting normativo possano trasformare il referendum in strumento di legislazione indiretta, alterandone la natura originaria.
I pericoli dell’insuccesso referendario
L’effetto legittimante sulle leggi contestate
Un referendum fallito (per inammissibilità, mancato quorum o esito negativo) produce spesso un effetto boomerang, rafforzando politicamente la legge oggetto della contestazione.
L’esperienza del referendum sul taglio dei parlamentari (2020) mostra come l’insuccesso referendario venga interpretato come avallo popolare alle riforme, anche quando le ragioni del fallimento attengono a fattori estranei al merito (6).
La crisi di rappresentatività e la sfiducia istituzionale
Il ricorso sistematico a referendum “propagandistici” rischia di svuotare lo strumento di credibilità.
I dati ISTAT rivelano che il 78% degli italiani considera i referendum moderni poco comprensibili nella formulazione, mentre il 63% li percepisce come strumenti di lotta politica più che di partecipazione civica (6).
Questa sfiducia mina le basi stesse della democrazia diretta.
Alternative percorribili per l’abrogazione legislativa
L’iniziativa legislativa popolare
L’art. 71 Cost. riconosce a 50.000 elettori il diritto di presentare progetti di legge, meccanismo spesso trascurato a favore dello strumento referendario.
La forza di questo istituto risiede nella sua capacità di obbligare il Parlamento all’esame parlamentare, anche in assenza di volontà politica.
Il caso della legge sul fine vita (2019), nata da una proposta popolare dopo anni di stallo, dimostra come l’iniziativa possa funzionare da catalizzatore del dibattito istituzionale (3).
Strategie di drafting normativo
L’efficacia dello strumento dipende dalla capacità tecnica di redigere testi legislativi compatibili con l’ordinamento.
La proposta di legge sul lobbying avanzata dalla coalizione #Lobbying4Change (2024) illustra come un’articolata definizione dei soggetti legittimati, unita a meccanismi di trasparenza vincolanti, possa trasformare una richiesta popolare in un disegno di legge tecnicamente inattaccabile (21).
Il ricorso alla giustizia costituzionale
L’azione popolare per conflitto di attribuzione (art. 134 Cost.) consente ai cittadini di sollevare questioni di legittimità costituzionale quando una legge invade la sfera di competenza di altri enti.
La sentenza n. 151/2024 ha confermato che la Corte valuta l’interesse a ricorrere anche su norme già abrogate, purché ne permangano gli effetti concreti.
Questo approccio bypassa i limiti materiali del referendum, permettendo di attaccare leggi escluse dall’art. 75 come quelle tributarie o di bilancio.
Sebbene sia uno strumento tecnico e poco conosciuto, ha il vantaggio di bypassare i limiti materiali del referendum, permettendo di attaccare norme incostituzionali anche in materie escluse dall’art. 75 (5).
La tutela dei diritti fondamentali
La giurisprudenza costituzionale ha sviluppato una sofisticata dottrina del “controllo diffuso” che consente ai giudici ordinari di sollevare questioni di legittimità su richiesta delle parti.
Il caso della legge Severino (2012), dichiarata parzialmente incostituzionale per contrasto con il principio di personalità della pena, dimostra l’efficacia di questa via giudiziaria (16).
La mobilitazione politica istituzionale
Le petizioni parlamentari e le audizioni pubbliche
Il regolamento della Camera (art. 127) riconosce alle petizioni con oltre 50.000 firme il diritto a un dibattito in aula.
L’emendamento “Salva precari” alla legge di bilancio 2023, ottenuto dopo una campagna di sole 200.000 sottoscrizioni, illustra come questo strumento possa produrre effetti legislativi tangibili (6).
Parallelamente, le audizioni in commissione consentono ai gruppi organizzati di influenzare direttamente il processo decisionale.
Il ruolo dei consigli regionali
La sentenza n. 16/2008 ha riconosciuto alle regioni il potere di promuovere conflitti di attribuzione contro leggi statali ritenute invasive delle competenze locali.
Questo strumento ha permesso alla Sardegna di bloccare nel 2023 l’applicazione di norme nazionali sul turismo, dimostrando l’efficacia del federalismo legislativo come forma indiretta di abrogazione (22).
La pressione internazionale e gli strumenti sovranazionali
Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo
L’art. 34 della Convenzione EDU consente ai cittadini di impugnare leggi nazionali contrastanti con i diritti fondamentali.
La condanna dell’Italia nel caso “Lopez Guerra” sul carcere duro (2022) ha costretto il legislatore a riformare l’ordinamento penitenziario, mostrando come lo strumento sovranazionale possa produrre effetti abrogativi indiretti (5).
Le direttive UE come limite all’arbitrio legislativo
Il principio del primato del diritto comunitario (art. 117 Cost.) obbliga il giudice nazionale a disapplicare le leggi contrastanti con gli obblighi UE.
La sentenza della Corte di giustizia sul caso “Taricco” (2017) ha di fatto abrogato numerose norme italiane in materia prescrittiva, dimostrando l’efficacia dell’integrazione europea come contrappeso al potere legislativo (23).
Le vie negoziali e la mediazione politica
Gli accordi Stato-regioni
La Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni (art. 114 Cost.) offre un forum per rinegoziare l’applicazione di leggi controverse.
L’accordo del 2024 sul federalismo sanitario ha di fatto modificato 15 articoli della legge 833/1978 senza passare per l’iter parlamentare, dimostrando l’efficacia della via pattizia (22).
Le commissioni bicamerali ad hoc
L’istituto della commissione d’inchiesta (art. 82 Cost.) può trasformarsi in strumento di pressione abrogativa.
La commissione sul sistema bancario (2023-2025) ha prodotto raccomandazioni che hanno portato alla modifica di 8 leggi in materia di crisi d’impresa, mostrando come l’indagine parlamentare possa orientare l’agenda legislativa (21).
L’esperienza giurisprudenziale recente dimostra che nessuno strumento singolo può garantire risultati certi nell’abrogazione legislativa.
La combinazione tra iniziativa popolare, ricorso costituzionale e pressione internazionale si rivela la strategia più efficace, come dimostra il successo della campagna per la legge sul lobbying (22).
Tre elementi appaiono decisivi: 1) l’integrazione tra strumenti giuridici e mobilitazione sociale; 2) l’uso strategico del diritto comparato per evidenziare contrasti normativi; 3) la sinergia tra livelli istituzionali (locale, nazionale, europeo).
La sentenza n. 199/2012 sul divieto di ripristino normativo (16) suggerisce infine che l’abrogazione ottenuta per via giudiziaria garantisce maggiori garanzie di stabilità rispetto all’esito referendario, imponendo al legislatore oneri motivazionali più stringenti per eventuali reintegrazioni.
È necessaria una riforma dello strumento referendario
L’analisi condotta rivela come il referendum abrogativo versi in una crisi multifattoriale che ne limita l’utilità pratica pur senza intaccarne il valore simbolico.
La soluzione non risiede nell’abbandono dello strumento, ma in una riforma organica che ne ridefinisca parametri e finalità.
Tre appaiono le direttrici prioritarie: 1) l’introduzione di un preventivo parere obbligatorio della Corte costituzionale sulla formulazione dei quesiti; 2) la creazione di un comitato tecnico-scientifico indipendente per la redazione dei testi referendari; 3) l’istituzione di quote differenziate di quorum basate sulla tipologia di legge coinvolta.
Queste proposte, ispirate a modelli europei come il Bundesverfassungsgericht tedesco, potrebbero restituire al referendum abrogativo la funzione di termometro democratico prevista dai padri costituenti, trasformandolo da arma politica a strumento di partecipazione consapevole.
Carlo Makhloufi Donelli
Nato a Villerupt (F) il 12.02.1956 – Studioso e Ricercatore in fisica quantistica applicata a biologia molecolare e neuroimmunologia – Membro del board di ricerca scientifica di diverse organizzazioni nazionali ed internazionali – Ideatore e Coordinatore del progetto EDIPO «Eliminazione isole di plastica oceaniche»
Fonti consultate:
- https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2024/09/IL-REFERENDUM-ABROGATIVO-DOPO-LA-TORNATA-DEL-2022-1.pdf
- https://it.euronews.com/2025/01/21/perche-la-corte-costituzionale-ha-bocciato-il-referendum-abrogativo-sullautonomia-differen
- https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/06/Carnevale-1-2020-D-rev.-2.pdf
- http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2013/04/Gigliotti-La-reviviscenza.pdf
- https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/Parigi201304_Criscuolo.pdf
- https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/gli-annali/annali-2023-1/19-perchinunno.pdf
- https://www.ilsole24ore.com/art/autonomia-quorum-rischio-inammissibilita-tutte-incognite-referendum-AF4d8AcC
- https://www.notaio-busani.it/it-IT/diritto-abrogazione.aspx
- https://www.diritto.it/referendum-abrogativo-i-limiti-di-ammissibilita/
- https://gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Bruno_Brancati_-_Preservare_il_referendum_abrogativo.pdf
- https://criticaliberale.it/2022/06/09/giustizia-i-pericoli-del-referendum-perche-non-andare-a-votare/
- http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf;jsessionid=dbpSLSrUdDSeJMPGGX6hrA__.ntc-as2-guri2a?dataPubblicazioneGazzetta=20130220&numeroGazzetta=8&tipoSerie=S1&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&numPagina=270&estensione=pdf&edizione=0
- https://ildiritto.it/amministrativo/il-referendum-abrogativo/
- https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/anticipazioni/referendum_abrogativo/index.html
- https://www.gruppodipisa.it/images/convegni/2024_Convegno_Catanzaro/Convegno_GdP_2024_Catanzaro_Relazione_provvisoria_Stefania_Leone.pdf
- https://giurcost.org/contents/giurcost/studi/Ferri4.pdf
- https://www.iusinitinere.it/evoluzione-e-possibili-sviluppi-futuri-del-referendum-abrogativo-44467
- https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/Costituzionalismo_201902_706.pdf
- https://www.valigiablu.it/referendum-giustizia-quorum-risultati-flop/
- https://www.treccani.it/enciclopedia/abrogazione_(Diritto-on-line)/
- https://www.thegoodlobby.it/campagne/lobbying-italia/
- https://giurcost.org/contents/media/posts/24801/padula5.pdf
- https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1242/tabellalimitireferendumabrogativo.pdf


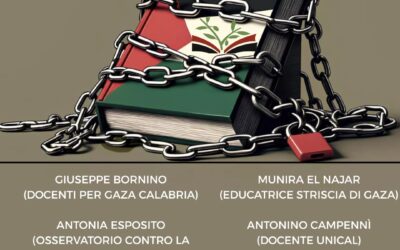

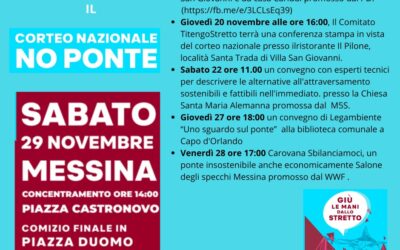
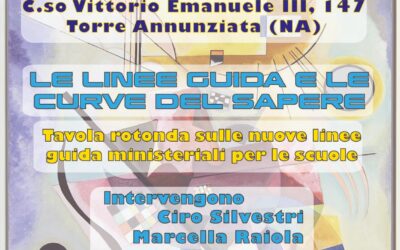
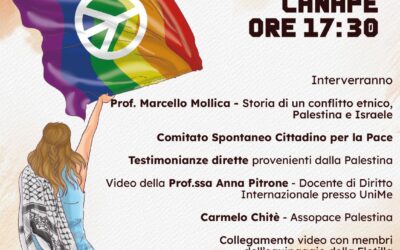
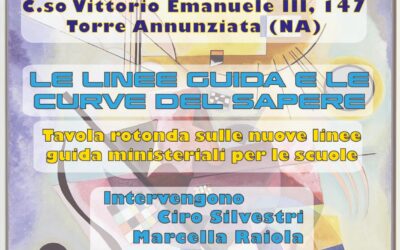



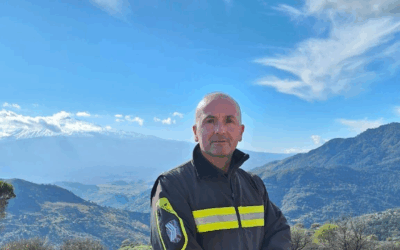

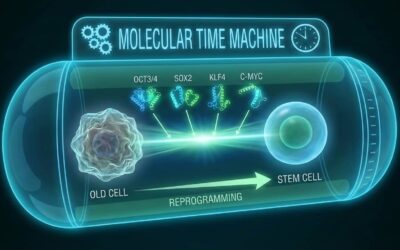
0 commenti